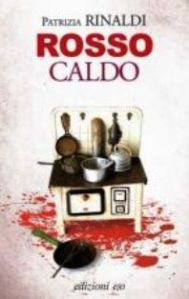Leonhard Frank pubblicò nel 1917 Der Mensch ist gut. Novellen. Paola Del Zoppo ha curato l’edizione italiana, L’uomo è buono, dei racconti di Frank, che ha tradotto per la casa editrice Del Vecchio. Un racconto lungo – Die Ursache / L’origine del male, pubblicato da Frank per la prima volta nel 1915 – e le cinque “novelle” de L’uomo è buono compongono il volume, che ha accompagnato, nella sua articolazione e nella mia lettura, un viaggio e cinque albe. Oggi, 19 ottobre 2014, nel giorno della Marcia per la Pace Perugia-Assisi, cammino e penso, penso e cammino, porto con me questo libro potentissimo, chiaro e profondo, che attraversa il dolore, non lo ignora, lo raccoglie e chiama, con la voce di chi ha conosciuto lo strazio e la perdita, di chi ha smascherato la menzogna delle parole di propaganda, a una rivoluzione che ripudia le armi e invita a pensare, sempre: «Solo chi pensa può portare la pace». Ringrazio Paola Del Zoppo e la casa editrice Del Vecchio per questo estratto da La vedova di guerra, una delle cinque Novellen della raccolta L’uomo è buono.
Anna Maria Curci, 19 ottobre 2014
Solo chi pensa può portare la pace
Il tram non poteva più passare. I vetturini erano in piedi, i passeggeri sporgevano la parte superiore del corpo fuori dalle vetture come gargoyle. La folla aumentava rapidamente. Anche le viuzze che conducevano alla piazza erano già nere di gente.
La guardia prese per il braccio la vedova di guerra: – Adesso vada a casa.
– A casa? Perché, ho una casa? – La sua risata era il ruggito di una belva e strappò risate di scherno da parte di mille bocche femminili. Con uno strattone si liberò dalla presa della guardia.
Un volto di donna, beffardo e pericoloso, puntò la guardia agli occhi: – Provi un po’ lei a stare sempre in una casa dove non c’è più nessuno. […] La vedova dell’agente faceva con le mani piccoli movimenti corrispondenti agli spasmi sul suo volto, e si sforzava di spiegare agli altri che tormento fosse, per lei, quando le capitavano sotto gli occhi un vecchio vestito, una maglia di lana, un paio di pantaloni lisi del marito. […] Allora il cameriere fece appello al profondo dei desideri e gridò: – Vogliamo la pace!
Subito i volti della gente si distesero. Una nuvola di calda passione si addensò e scoppiò. La parola “pace” echeggiò forte tuonando per alcuni minuti intorno al cameriere che, in piedi sul vagone, urlò nell’improvviso gelido silenzio: – Ma possiamo aiutare la pace, solo se sappiamo e ammettiamo che anche noi siamo corresponsabili dello scoppio della guerra.
– Che sta dicendo quello? Cosa? – La vedova dell’agente era come paralizzata dall’indignazione e dallo stupore.
– Solo chi pensa può portare la pace… Noi non pensiamo. Noi pensiamo solo a noi stessi.
I volti mutarono, si velarono. Si aprì un vuoto tra la folla e il cameriere.
Stava dicendo: – Già prima della guerra non pensavamo. Eravamo macchine senza pensiero, senza opinione. Perciò ognuno di noi è corresponsabile della guerra.
– Corresponsabile? Non abbiamo voluto noi la guerra. Il popolo no…! Noi no! – Un’onda di rabbia scosse la folla.
– Dobbiamo prima tornare alla verità. L’abbiamo dimenticata. Lasciatevelo dire. Dovete lasciarvelo dire. Noi non abbiamo per niente riflettuto su cosa fosse buono e giusto, non abbiamo per niente pensato, e nel corso della nostra vita abbiamo lasciato crescere in noi il male finché non si è fatto abitudine, finché non abbiamo creduto che il male: ovvero egoismo, violenza, potere, successo e denaro fossero le aspirazioni più alte dell’essere umano. E questo principio freddo e micidiale, reso ovvio, comune a tutti gli europei, di voler sopraffare i propri simili, avrebbe portato gli esseri umani a uccidersi gli uni con gli altri… E poi si parla di onore, eroismo, morte da eroe, si parla di campo dell’onore.
Allora lì la vedova dell’agente di assicurazioni, fendendo la corrente di urla di approvazione, attraversò la folla, che si apriva davanti ai suoi pugni stretti, fino al vagone. – Corresponsabili della guerra? Noi? Mio marito? Mio marito voleva solo vivere, – urlava fuori di sé. Si arrampicò, venne tirata giù, si arrampicò di nuovo fino alla metà.
E ancor prima che potesse essere di nuovo trascinata giù dal vagone, il cameriere si piegò e le toccò dolcemente con la mano la testa scapigliata.
– Non parlare così, – minacciò un uomo. Urlando, dei ragazzi non ancora cresciuti e non ancora pronti per le armi si arrampicarono sul muro.
– Noi tutti, senza pensare alle conseguenze, non abbiamo puntato ad altro che a riportare il maggior successo possibile, incuranti della possibilità di distruggere l’immagine della nostra anima, incuranti della possibilità di procurare dolore e miseria a un altro essere umano come noi. Noi tutti abbiamo riconosciuto e ammirato come autorità i violenti che più di tutti accumulavano potere, possesso e autorità nelle proprie mani… Noi tutti ci sentivamo fieri quando i nostri malconsigliati figli intonavano canzoni di battaglia e assassinio. E quando le autorità al potere facevano marciare le truppe, noi lanciavamo grida di giubilo e ci entusiasmavamo. Giubilo quando giungevano le prime notizie di vittoria. Giubilo. E non ci preoccupavamo se, nell’assalto di una fortezza, cinquantamila uomini venivano spappolati, dovevano essere spappolati affinché, in quell’atto assassino di mostruosa violenza, i potenti potessero accrescere la loro potenza e i possidenti il loro possesso. Non ce ne preoccupavamo perché noi stessi non avevamo altro in noi che il desiderio di successo, possesso e potere. E questo desiderio lo chiamavamo, con una menzogna, patriottismo. Dobbiamo portare la pace. Siamo corresponsabili della guerra. Siamo assassini. Dobbiamo purificarci.
[…] Lui aveva l’audacia di chi, dopo aver sofferto eccessivo dolore personale, non teme più per sé alcun pericolo.
– Abbiamo il diritto di invocare la pace solo se non adempiamo a falsi doveri, come abbiamo fatto fino a ora senza pensare e senza avere un’opinione. E possiamo davvero far sì che ci sia pace sulla terra solo se smettiamo di mettere al centro della vita le grandi nullità, se cominciamo a essere non automi senz’anima che agiscono solo per abitudine, bensì uomini che sanno che l’espressione: «Nel momento in cui hai intenzione di danneggiare un’altra persona, stai danneggiando te stesso» è una legge inconfutabile. Siamo impoveriti. L’abituale sfruttamento e l’abituale accumulazione di proprietà per la quale gli europei oggi si uccidono gli uni con gli altri, ci hanno resi poveri. La cattedrale dell’umanità è crollata, nell’uomo europeo. Per questo diventa ufficiale o agente di borsa; per questo è avido e brutale, per questo ingrassa, fa la guerra, fa lavorare per sé chi non ha successo, lavorare così duramente da non lasciare, alla maggior parte del nostro popolo, neanche un minuto per prendere coscienza di sé, tanto che i poveracci caduti nell’inganno non possono più credere alla fratellanza dell’uomo.
La folla, scossa dalle parole del cameriere, si era fatta esitante; nacquero sentimenti mai provati, cominciarono a vibrare, risuonarono e si addensarono in esclamazioni di approvazione.
Lì la vedova dell’agente di assicurazioni urlò una frase che colpì nel centro dell’animo chi ascoltava, e che, con progressive aggiunte passò di bocca in bocca, così che il cameriere all’improvviso si sentì avvolto da migliaia di urla: – Tutto il popolo precipitato nel dolore…! Milioni di morti…! Fame! Vittorie in guerra! Farabutti!
Il cameriere disse: – Le nostre autorità hanno potuto farci marciare, impiegare ciascuno di noi per macellare uomini, trasformare tutta l’Europa in un mattatoio umano, perché noi abbiamo sempre pronunciato solo le parole e pensato i pensieri che ci sono stati forniti dalle autorità. Dalle autorità che, con la stessa bocca con la quale danno l’ordine di sparare sugli uomini, ci parlano di cultura e civilizzazione. Dieci milioni di uomini sono morti. Perché? Per che cosa sono morti, questi dieci milioni di uomini? Uno solo di voi ha pensato al perché gli europei macellano i loro giovani? Perché si è scatenata questa guerra? La verità è che il nostro popolo senza opinione, senza capacità critica, ingannato con raffinatezza, non può neanche saperlo. Lo sanno solo gli sfruttatori della guerra.
La vedova dell’agente di assicurazioni era impietrita. Anche la folla era impietrita.
La robusta vedova di guerra del cui marito non si erano ritrovati né la testa, né il segno di riconoscimento, mise il suo bidoncino di petrolio sul vagone, ai piedi del cameriere. Tutte le finestre sulla piazza erano nere di uomini.
Il cameriere sapendo che la verità è dura, parlò incisivamente verso il basso, al volto cupo della folla:
– Abbiamo permesso che venissero costruiti cannoni, navi da guerra, macchine di morte. Li abbiamo pagati e ammirati. Anche se avremmo dovuto sapere che quelle macchine di morte da noi pagate, un giorno, si sarebbero rivoltate contro l’umanità e anche contro i nostri mariti, figli e padri. Era inevitabile… Poi viene detto e creduto, creduto dal nostro popolo che non ha opinione né pensieri, che dobbiamo difendere la patria. Si parla di eroismo e di campo dell’onore. Ma l’onore non era forse del tutto già morto ancor prima che cominciasse la guerra? È forse un onore uccidere degli esseri umani per il possesso e il potere? Se questo è onore, allora vogliamo essere senza onore, per poter vivere di nuovo con onore. Se questo è eroismo, allora vogliamo essere vigliacchi, così che il coraggio non muoia a questo mondo. Se questa è la ragione vogliamo essere irragionevoli, così che la ragione possa sopravvivere. Non volete tutto questo? Avete il coraggio di uccidere degli uomini e non avete il coraggio di essere umani?
Lo sguardo della folla muta ripeteva la domanda. Due cavalli da tiro, stretti tra la folla, si dimenavano. La vedova dell’agente di assicurazioni ebbe la sensazione fisica che l’oscurità in lei si facesse di un bianco accecante. La sua faccia era improvvisamente bagnata di lacrime.
Il cameriere tese la mano in avanti: – Dieci milioni di cadaveri! Dieci milioni di persone adesso sono morte. Il sangue che scorre da quei dieci milioni di assassinati (quaranta milioni di litri di sangue umano fumante) potrebbe sostituire per un’ora l’enorme getto d’acqua delle cascate del Niagara. Tutto il materiale rotabile delle ferrovie di tutta la Prussia non basterebbe a trasportare in una volta sola le teste troncate di quei dieci milioni di uomini. Civiltà! Immaginate un lungo treno della ferrovia: l’ultimo vagone è ancora a Monaco mentre il primo è già in stazione a Berlino e tutti sono pieni di teste umane sanguinanti. Civiltà! Si mettano i dieci milioni testa a testa, piede a piede! Ne viene una linea di cadaveri lunga 16.000 chilometri senza alcuno spiraglio, che corre intorno a tutta la Germania. Sedicimila chilometri di cadaveri! Civiltà!
Un singhiozzo risuonò come l’abbaiare di un cane. Volti disfatti si guardavano l’un l’altro. Occhi sbarrati. Domande senza parole. La vedova dell’agente di assicurazioni vedeva girare davanti agli occhi i colori e crollò sul petto del vicino.
– Io vi dico: di questa epoca del potere, della violenza, della menzogna e dell’autorità non rimarrà nulla eccetto l’orrore, e per le future generazioni una risata.
E lì aprì le braccia, così che dietro a lui il campanile della chiesa, illuminato di rosa dal sole crepuscolare, apparve come un gigantesco crocifisso:
– Vogliamo finalmente prendere coscienza, vogliamo pensare, ricordarci, che l’uomo è buono, e che è nostro fratello. Vogliamo finalmente strappare dai nostri cuori l’abitudine, la menzogna, l’avidità, l’ammirazione per la violenza, così che neanche il seme dell’umanità non ancora nata porti con sé il germoglio di nuovi assassinii… Ogni giorno vengono uccise diecimila persone, che tanto volentieri, ah!, così volentieri avrebbero ancora voluto vivere. E invece il ciabattino siede come sempre nella sua bottega e risuola stivali, il falegname fa i mobili, l’operaio sta davanti alla macchina, il commerciante è dietro il bancone; l’impiegato è lì che riempie fogli di carta e il ragioniere conteggia, il cameriere serve, mentre ogni giorno cadono e muoiono diecimila persone, che a loro volta hanno dovuto uccidere persone. Che follia! Se non vogliamo perdere il diritto a chiamarci uomini dobbiamo mollare martelli, pialle, scrivanie e macchine e correre per strada, afferrare il primo venuto per il braccio, e la nostra voce deve trapassargli il cuore: «Ogni giorno vengono uccise diecimila persone. Ma come possiamo lavorare, cercare il guadagno, dormire, mangiare, mentre ogni giorno vengono uccise diecimila persone? Non è possibile…». Vi dico: chi oggi, mentre diecimila persone al giorno muoiono orribilmente, alza la sua mano per lavorare è inumano. Perché lui lascia che le persone vengano uccise e non chiede: che devo fare, perché non vengano uccise?
Allora la vedova robusta, agitando il bidoncino di petrolio, scoppiò in una risata selvaggia. E le frasi: – Bisognerà pur vivere, che altro ci rimane? Dobbiamo guadagnare, mangiare, – dapprima da lei, poi urlate da mille bocche, salirono verso l’oratore ammutolito. Gridavano: – Cosa dobbiamo fare, quindi? Cosa? Cosa dobbiamo fare?
[…] Il cameriere disse: – Il mio giovane figlio è caduto. Il suo sangue sarebbe stato sparso inutilmente se in questo mare rosso bollente non si sciogliessero cupidigia e violenza. Se l’omicidio di massa non si mutasse in umanità e fratellanza.
L’uomo con la barba era sconvolto: – Farabutto! E la patria? La nostra sacra patria? I nostri beni più sacri? La nostra patria?
[…] Il cameriere disse: – La patria è una viuzza nella quale abbiamo giocato da bambini la sera, è un tavolo rotondo illuminato da una fioca lampada a petrolio, è la vetrina del negozio di coloniali nell’edificio accanto; la patria è, nel giardino, il noce, di cui abbiamo atteso il frutto, è la valle di un fiume, l’angolo della valle di un fiume; la patria è una vecchia porta grigia nel retro del giardino, il profumo delle mele che arrostiscono sulla stufa, è l’odore del caffè e dei dolci che si scaldano nella casa dei genitori, è uno stretto sentiero che, attraverso dei prati, riconduce in città, o va fuori, è una passeggiata su quel sentiero, l’affievolirsi di un canto infantile, la campana della sera di un giorno preciso della nostra infanzia… non è lo Stato (le organizzazioni del denaro, della menzogna, della violenza e dell’autorità) la patria dell’umanità, bensì il ricordo di istanti piacevoli dell’infanzia, il ricordo della prospettiva della vita abbellita dalle speranze.
In quel momento guardò il volto della folla e riconobbe chiaramente che nella grande maggioranza quei ricordi delle incessanti lotte per la vita, dei dolori della guerra, dell’odio contro chi l’aveva sprigionata, erano stati interiorizzati, e comprese che la sua parola non poteva ancora penetrare fino a quei cuori di vedova disgraziati, contratti. Solo in pochi si era risvegliato lo sguardo infantile che permette di guardare indietro alla vita passata.
Quando l’uomo con la barba volle risvegliare i sentimenti non più presenti per la patria con la parola “nazionale”, per la disperazione, nel cameriere esplose un’ira improvvisa, e lui si rivolse alla folla con queste parole: – Internazionale è ciò che è grande: l’arte, la scienza, la vita e la morte. […]
– Non potete arrestarci, metterci in prigione. Non si possono arrestare milioni di vedove di guerra!
Un fiotto di petrolio schizzò nell’aria privo di ogni colore. Cavalli impennarono. La carrozza ardeva vivida e fu trascinata rapida in corsa attraverso la piazza, seguita dalla folla.
[…]
Il cameriere sentì la lontana eco di diversi spari. Il tumulto in lontananza si fece di nuovo udibile. “Rivoluzione è sulla fronte della gente, e quello che è sulla fronte della gente, succederà”.
La piazza, svuotata dalla folla, appariva logora. Il crepuscolo, l’aria, l’essere gli fornirono un istante di luce.
(pp. 170-183)
____________________________
Leonhard Frank, L’uomo è buono, Del Vecchio Editore, 2014. ISBN: 9788861101067 | Pagine: 336 Traduzione e cura di Paola Del Zoppo
L’origine del male e L’uomo è buono vengono scritti ed elaborati nel primo anno della Grande Guerra. Leonhard Frank non cede alla mitizzazione del progresso, della potenza, dell’organizzazione e della necessità della guerra e decostruisce, nelle sue novelle, i percorsi che hanno portato alla tragedia: la tendenza alla sopraffazione e la propensione all’adattamento, alla conservazione dello stato delle cose per timore della sofferenza, il pessimismo. In L’origine del male Anton Seiler, un poeta messo a dura prova dagli eventi della vita eppure ancora fedele ai propri ideali, sente la necessità enigmatica di tornare nella sua città natale dove incontra per caso il suo sadico maestro di scuola. Un tentativo di riconciliazione si trasforma in delitto, e il poeta viene arrestato. Rischia la pena di morte. Sarà lo svolgimento del processo a farci conoscere la vera origine del crimine e le sue conseguenze. L’uomo è buono è un ciclo di cinque novelle: in ognuna un protagonista ci trasporta nella sua visione della guerra e della sofferenza. La sciagura e il dolore, mascherati da onore e sacrificio, vengono qui svelati in tutta la loro indigesta oggettività. La narrazione scoperchia il vaso di Pandora per affrontare la realtà dei mali uno a uno, in un energico slancio verso la reazione, verso l’ottimismo e la presa di coscienza della forza del singolo, perché “l’uomo potrà essere e sarà umano quando non sarà più costretto all’inumanità”.
Leonhard Frank nasce a Würzburg nel 1882 da una famiglia umile. Frequenta la severissima scuola evangelica, in una regione e una città di storia e cultura radicalmente cattoliche, e dopo il diploma di artigiano si iscrive all’Accademia di Belle Arti di Monaco per diventare pittore. Nel 1910 interrompe la propria formazione per recarsi a Berlino. Frank è una presenza costante nei caffè e nei circoli artistici, ma non vuole essere parte di nessuna cerchia: ritiene che ogni sistema sia finalizzato al mantenimento del potere e che in ogni cerchia si rischino dinamiche di sopraffazione. Riconosciuta la propria vocazione, dopo alcuni brevi racconti, dà alle stampe il suo primo romanzo, che vince subito il Premio Fontane. “Pacifista della prima ora”, si rifugia in Svizzera durante la Prima Guerra Mondiale, dove stringe amicizia con Alvarez del Vayo e frequenta gli artisti del Dada e gli scrittori engagé. Tornato in Germania, è controllato dal regime nazionalsocialista e costretto di nuovo all’esilio. Nel 1933 si sposta in Inghilterra, poi in Francia, dove viene internato nei campi di lavoro, poi finalmente riesce a fuggire in America nel 1940. Si stabilisce a Hollywood, scrive per la Warner Bros e frequenta Thomas Mann, Franz Werfel e gli intellettuali tedeschi ormai di casa in California. Infine si sposta a New York e poi torna in Germania, nel 1950. Ma l’accoglienza non è gloriosa quanto meriterebbe, e decide di spostarsi a Berlino Est, dove può contare sull’apprezzamento dell’amico Johannes Becher. Muore a Monaco nel 1961.