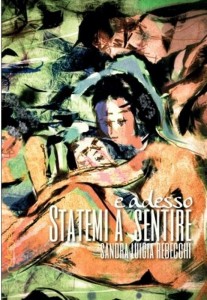Un tè nel deserto
(Viaggio nei campi profughi Saharawi con l’Associazione di Solidarietà e Amicizia con il Popolo Saharawi ASAPS “Enzo Mazzarini”)
Il mio viaggio nei campi profughi Saharawi inizia all’Aeroporto Internazionale di Fiumicino il 28 dicembre 2019. Ai desk dell’Air Algerie mi attendono i compagni di viaggio: alcuni, come Carmen Frasca (Presidente dell’Associazione ASAPS), conosciuti negli anni passati durante i progetti accoglienza dei “piccoli ambasciatori di pace”; altri conosciuti in quel momento. Dopo le presentazioni di rito e i convenevoli il nostro maggior problema è come imbarcare le numerose e pesantissime valigie senza pagare il sovraccarico previsto dalle leggi aeroportuali. Alla fine, riusciamo ad imbarcare tutto senza pagare alcuna tassa aggiuntiva. Siamo in possesso di un “visa collectif” da parte della Repubblica Algerina Democratica e Popolare: “… dans les campements des refugies Sahraouis de la region de Tindouf sur invitation de la representation du front Polisario a Rome”. Non è un semplice viaggio di turismo responsabile e solidale; no, è qualcosa di più che, alla partenza, ancora non so definire. Oltre ai bagagli porto, e partono, con me suggestioni letterarie e cinematografiche che mi accompagneranno per l’intera permanenza nei campi profughi.
Atterriamo ad Algeri dopo circa due ore di viaggio. Ci attende un aeroporto moderno mentre i primi pensieri vanno al film “La battaglia di Algeri” visto negli anni ’80 in un lontano cineforum a Napoli. E, subito, penso: “Mai avrei pensato, nella mia vita, di venire o sostare per qualche ora nella città di Algeri”. Considerata terra difficile e violenta … un pensiero immediato alla “Legione Straniera” e alla constatazione che con meno di due ore siamo al di là delle coste del “mare nostrum”, il nostro Mediterraneo. Soltanto due ore di aereo e quante vite – recise in mare – potrebbero essere salvate! Sì, i corridoi umanitari, rimangono – forse – la soluzione più veloce e più sicura per la piaga dell’immigrazione clandestina. Ma, questo, naturalmente è un altro argomento. Una digressione spontanea e fulminea subito messa a tacere per pensare alla meta del nostro viaggio.
Ci aspetta una giornata di attesa estenuante all’aeroporto nazionale di Algeri. Infatti, il volo per Tindouf – ultimo avamposto dell’Algeria – è previso per le tre di notte. Arriviamo nell’ex città militare a notte fonda. La prima impressione, superati i controlli e dopo aver compilato i moduli di ingresso, è un piccolo aeroporto color seppia offuscato da luci gialle che mi rimanda, immediatamente, alle tipiche atmosfere del film “Casablanca”. Attendo Humphrey Bogart, con il suo immancabile soprabito, mentre nella testa risuona il refrain della famosa “Play it, Sam”. Mi guardo intorno e cerco di catturare i volti, gli sguardi: siamo quasi tutti “étrangers” in missione umanitaria grazie alle numerose ONG e associazioni che operano in questi territori.
Fuori, ad attenderci, ci sono le jeep e i relativi autisti che ci faranno da guida e da “capo-cammellieri” durante tutto il nostro soggiorno. Un altro benvenuto ci viene dal cielo stellato sopra di noi; un cielo così lo avevo visto soltanto in Somalia, tanti anni fa. Una coperta blu indaco trapuntata di luci e di stelle. Cerco di individuare il Carro dell’Orsa Maggiore (che individuerò soltanto uno degli ultimi giorni) accanto ai “tre mercanti”, ben visibili e scintillanti. Viene a confortarmi l’amico Kant: “Due cose riempiono l’animo di ammirazione e venerazione sempre nuova e crescente, quanto più spesso e più a lungo la riflessione si occupa di esse: il cielo stellato sopra di me, e la legge morale in me”.
Primo posto di blocco, se così si può chiamare: una garitta che ricorda – fotograficamente – alcune scene de “Il deserto dei Tartari”. Dall’aeroporto fino al confine del primo campo siamo accompagnati dalla scorta militare algerina: per la nostra incolumità. Un tragitto surreale. Così come surreali sono le emozioni e le sensazioni che si rincorrono e si sovrappongono nella mia mente.
Arriviamo a casa di Salek quasi alle prime luci dell’alba. È bello ritrovare un amico conosciuto in Italia grazie al progetto accoglienza dei bambini Saharawi. Sulla tavola, all’europea, è già imbandita la colazione delle prossime ore. Un’ora o forse meno di riposo e già siamo in partenza per Dakhla, il più lontano campo profughi (circa 170 km da Tindouf) quasi al confine con il Mali. Abdul – il nostro autista, la persona che il protocollo del Polisario ha affidato al nostro gruppo – ha dormito con noi e, prima di partire, ci ha già preparato il tè. Con il passare dei giorni ci affezioneremo sempre più a questa cerimonia. In una dimensione dello spazio dove il tempo è una variabile infinitesima questo antichissimo rituale riveste una importanza fondamentale. Fulcro della casa, dell’ospitalità, della famiglia, del ritrovarsi tutti insieme attorno ad un piccolo braciere, una teiera come se – fuori – non ci fosse la vita che pulsa.
Iniziamo il nostro viaggio percorrendo l’unica strada asfaltata dei campi. Una lunga nera linea retta che taglia in due il “deserto dei deserti”. Tentiamo di fare qualche video, qualche foto ma già dalle prime ore capiamo che i mezzi tecnologici non possono minimamente racchiudere ciò che stiamo vedendo e vivendo. Il nulla, il nulla a 360° gradi. Deserto, non quello delle immagini pubblicitarie, ma il deserto fatto veramente di nulla. Una distesa infinita di niente e, immancabilmente, tornano alla mente le storie dalle mille e una notte di questi popoli appartenenti a queste latitudini e longitudini; film come “Un thè nel deserto”, “Il paziente inglese” o altri tipi di deserto (nello specifico quello visto in Samaria dove si svolse la famosa parabola del Buon Samaritano) ma nulla hanno a che vedere con lo scenario che si presenta ai nostri occhi. In alcuni punti, grazie a depressioni e a protuberanze del suolo create dal continuo gioco del vento – il Ghibli – sulla sabbia, sembra di essere sulla Luna.
Arriviamo in tarda mattinata nel campo profughi più lontano e più povero, perché qui, a causa della maggiore distanza rispetto agli altri campi gli aiuti umanitari internazionali arrivano con più difficoltà. Accolti calorosamente nella “jaima” (tenda, ogni famiglia ne possiede una accanto alla propria casa) dalla famiglia di Debha e Azman, veniamo catapultati nella vita quotidiana dei Saharawi. L’Africa, il Sahara ci dà il benvenuto con la luce che filtra attraverso i variopinti tessuti della tenda. Ma il benvenuto più bello è senz’altro quello che ci riservano i bambini. Si siedono accanto a te, ti guardano, ti sorridono e, dopo qualche iniziale diffidenza, ti prendono per mano e ti portano a conoscere il loro mondo. Ti accompagnano al recinto delle capre, ti presentano ai loro amichetti cercando di farti sentire a tuo agio come meglio possono. Ti aiutano, ti indicano la strada, sono attenti che tu non ti faccia male, ti proteggono in una sorta di scorta in questo mondo primordiale e vero. Sono felici della tua presenza e te lo fanno capire in mille modi. Si tolgono quello che hanno per darlo a te: il poco che hanno lo condividono con gioia e serenità. Dopo mezza giornata sei una di loro: ti donano e ti aiutano ad indossare la “melfa” (abito tipico della cultura femminile Saharawi. È composta da un unico telo lungo circa cinque metri che le donne si avvolgono attorno al corpo e alla testa. Serve per ripararsi dal sole e dal vento. La veste tradizione maschile è il “dhra”, simile alle tuniche blu dei Tuareg. Per proteggere il capo, invece, gli uomini utilizzano il “thelm”, un turbante che viene avvolto sulla testa e sul viso), ridono delle tue imbranataggini: togli le scarpe, metti le scarpe … e, alla fine, ti ritrovi a camminare a piedi scalzi sulla nuda sabbia. Sorridi, sei felice di queste giornate ricche di umanità.
Il giorno dopo ci rechiamo al Municipio del campo: l’architettura continua a ricordarmi il fortino di Drogo: il pantone azzurro del cielo – accecante e brillante – fa da contrasto con i muri bianchi, un po’ sgretolati, e la bandiera della RASD (Repubblica Democratica Araba dei Sahrawi) che ricorda il sacrificio, il dolore e le speranze di un intero popolo. Anche qui deve accadere “qualcosa”, dovrà accadere “qualcosa” ma non si sa quando …
Il sindaco e la vice-sindaco hanno chiamato a raccolta le famiglie cui andranno i soldi delle adozioni a distanza. Una cosa che mi ha sempre colpito e affascinato sono i colori sgargianti delle stoffe e dei vestiti delle donne africane, in genere: icone bellissime di femminilità e sensualità. Un’esplosione di colori, di linee e disegni. Quest’anno 30 famiglie italiane hanno adottato altrettante famiglie Saharawi. Dignitose e fiere nella loro compostezza e deferenza ringraziano con lo sguardo e, nonostante il loro nulla, donano regali e piccoli oggetti artigianali da portare alle rispettive famiglie italiane che hanno deciso di sostenerle nelle loro difficoltà. Non nascondo che in quella mattinata ho vissuto momenti di vera commozione.
Fuori ancora il deserto, tende, baracche, il nulla, il vento, il sole, nessun albero e, in lontananza, un carretto trainato da un asino. Accanto dei bambini. Uno di loro ha uno zaino in spalla e, in italiano, mi dice: “Io madras”. Le scuole, in questo periodo, sono chiuse; evidentemente le scuole religiose no. Tuttavia, anche se di religione mussulmana, qui esiste un Islam moderato, più vissuto quotidianamente che non professato o reclamizzato a gran voce. Mi pare di non avere visto alcuna moschea, in nessun campo.
Proseguiamo la nostra visita di Dakhla recandoci all’ospedale comunale: anche questo isolato e sperduto nel nulla, tra dune di sabbia. Il responsabile ci fa visitare l’intero complesso … pensiamo ai nostri ospedali. Scopriamo che c’è anche una moderna sala operatoria … forse la nostra coscienza si placa un po’…
Ritorniamo alla nostra casa, dalla nostra famiglia. Abbiamo ancora un po’ di difficoltà a delineare le varie discendenze e parentele: figli, cugini, nipoti. Qui vige ancora il senso della “famiglia”. Nessun bambino sarà mai orfano perché ci sarà sempre qualcuno (della famiglia o vicino di casa) che si prenderà cura di lui. Cerchiamo di rispettare le regole e le tradizioni di questo fiero popolo: nei rituali, nei pranzi e nelle cene, nel rispetto dei bambini, delle donne e degli anziani.
Le stanze principali delle case sono confortevoli. Cuscini piccoli e grandi sono l’unico arredamento. Nei campi profughi non vi è nulla di definitivo perché basta il minimo indispensabile per sopravvivere bene. Lo ripetono da 44 anni da quando il controllo dei loro territori è passato dalla colonia spagnola a quella – illegale e sanguinaria – imposta dall’invasione marocchina nel 1976. Non utilizzare il cemento – qui – è una scelta politica. Una sera, all’imbrunire, i nostri piccoli amici ci hanno preso per mano e ci hanno portato a vedere la “casa delle bottiglie”. Un progetto di Tateh Lehbib per realizzare case con bottiglie di plastica riempite di sabbia. In tutti i campi ci sono 25 case realizzate in questo modo.
L’ultimo appuntamento, a Dakhla, sarà con le dune. Un naturale parco dei divertimenti … difficile dire quali siano state le emozioni e le sensazioni in quei momenti!!!
Lasciamo, a malincuore Dakhla. Forse è troppo dire che dopo soltanto due giorni ci siamo affezionati ma, si sa, non esistono regole del cuore. Alcuni dei bambini e bambine si nascondono o vanno lontano … hanno ragione: il saluto presuppone un distacco. Ma, ormai, un filo che ci terrà uniti per sempre è stato creato.
Ritorniamo a Auserd, a casa di Salek. È il 31 dicembre e solo la torta fatta da Kaltum “Welcome 2020” ci ricorda questa data. Per il pomeriggio è stata organizzata una festa con i bambini e bambine ospiti, nell’estate 2019, in alcuni comuni del Lazio. Rivederli lì mi fa un certo effetto … trattengo, molto spesso, l’emozione e, discorrendo in spagnolo, arabo e italiano, trascorriamo il pomeriggio tra risate, fotografie, giochi e sorrisi. Ho portato con me il gioco “Uno” e le carte da gioco italiane. Attorno ad un tavolo organizziamo giochi di prestigio (tre trucchi imparati da ragazzina da mio padre che riciclo sempre in queste particolari occasioni) e la famigerata “scopa” italiana così da esercitare un po’ di matematica e imparare i numeri. Disegniamo e coloriamo insieme. Regalo a Mariude e Rafia i libri “Piccolo blu e piccolo giallo” e “Tutti in coda”. I “silent book” (come socia IBBY) li ho utilizzati spesso con i migranti sia a Lampedusa, sia a Roma. E, anche qui, creano “ponti” inaspettati. La giornata sembra non avere più fine … rimani senza parole di fronte al rubeo tramonto, aspetti l’imbrunire e l’accensione del cielo, cerchi un po’ di solitudine (difficile da queste parti) per riflettere un po’ e per elaborare tutto ciò che si sta vivendo ma … all’interno già ci aspetta il “thè con il latte” della sera e le chiacchiere in famiglia.
Il giorno dopo è prevista la visita al “muro”: 2720 km di muro (di sabbia e fango) in pieno deserto; 20 mila km di sfilo spinato controllato a vista dall’esercito marocchino e 6 milioni di mine antiuomo e anticarro. Siamo un bel gruppo – scortati – e ben protetti. Nonostante tanti diktat e proclami – al mondo – ci sono ancora, troppi muri “dimenticati” e che dividono. Quasi due ore di vero “Camel Trophy” per arrivare nel punto consentito. Una Parigi-Dakar in piena regola … ma lo spirito con cui ci avviciniamo alla meta sicuramente è diverso. Scrutiamo i nostri amici Saharawi e vediamo, nel loro volto, nel loro sguardo, tutto il loro dolore, tutte le loro speranze. In religioso silenzio percorriamo un breve tratto del deserto … delimitato da alcune pietre per evitare le mine e … in lontananza vediamo piccoli minuscoli puntini neri. È l’esercito marocchino che ci ha visto da lontano. Si apre una bandiera della RASD e si fa il segno di vittoria con le dita. Un piccolo omaggio, da parte nostra, al loro sacrificio, alle loro scelte, alla loro vita.
Durante il ritorno ci fermiamo, in pieno deserto, per il pranzo. Il solito braciere per il thè, un piccolo fuoco acceso all’impronta, spiedini di carne di cammello, pane, datteri e “cous cous”. E tanta libertà, nonostante tutto.
È difficile tenere una sorta di diario di viaggio. Troppe le emozioni, le suggestioni, le impressioni. Forse la cosa migliore è lasciarsi trasportare da questo flusso ininterrotto di esperienze di vita, in un continuo altalenarsi tra idee acquisite, pregiudizi e smentite. Stiamo vivendo il “deserto”: uno dei luoghi più inospitali della Terra ma, nello stesso tempo, uno dei luoghi più ospitali (qui l’ospite è veramente “sacro”). Continua a leggere